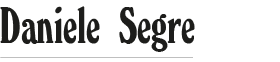Gilda Zazzara – “Venetica”, (XXII) 18, 2008, pp. 177-185
Daniele Segre, il suo film Morire di lavoro è interamente basato sulle voci di lavoratori edili e dei loro familiari circa sicurezza, salute e morte nel settore delle costruzioni. Siamo reduci da un’esperienza con studenti e sindacalisti in cui il tema della sicurezza sul lavoro è stato affrontato proprio attraverso le storie di vita di persone infortunate, oppure di parenti di lavoratori che avevano perso la vita. Per questo vorrei cominciare proprio dall’incontro e dal rapporto con le donne e gli uomini che le hanno consegnato i propri racconti.
Se posso, prima vorrei fare una premessa e spiegare il motivo per cui ho deciso di fare questo film, visto che nessuno me l’ha commissionato.
Sì, certo.
L’ho fatto per motivi di mia personale indignazione rispetto al bollettino di guerra che quotidianamente annunciano giornali radio e telegiornali. Una situazione assolutamente deprecabile per un paese che si definisce civile. Ho provato ad attivare un rapporto di collaborazione con il servizio pubblico radiotelevisivo, la Rai, per la produzione del film, e ho avuto un diniego su tutti i fronti, a partire da Rai Tre, che era stata l’unico interlocutore durante la fase preparatoria. Una volta realizzato, ho fatto vedere il film a Rai Cinema, e pur ricevendo un grande plauso e attenzione, ancora oggi, quando ne hanno parlato tutte le reti televisive – siamo a novembre, il film è stato mostrato a gennaio, ancora prima dell’anteprima alla Camera dei Deputati –, non ho avuto una risposta.
Ma con quali motivazioni?
Nessuna motivazione. Come direbbe Pasolini, un “silenzio assordante”. La situazione è delicata e emblematica. Dal momento in cui il film è stato proiettato in anteprima alla Camera dei Deputati si sono susseguiti in continuazione appelli da parte dell’associazione Articolo21, attraverso l’onorevole Giuseppe Giulietti e altri interlocutori politici e sindacali, compresi sindacati di destra come l’Ugl della Polverini, lei stessa presente all’anteprima. Ma la Rai, totalmente assente all’anteprima – assenti il presidente e il consiglio di amministrazione, che erano stati invitati – non ha mai dato riscontro a questi appelli, e c’è stato un silenzio su cui occorrerebbe riflettere. Anche perché si tratta di un servizio pubblico in cui chi è in carica, e lo è ancora, è stato nominato da un governo di sinistra, quindi il silenzio diventa ancora di più emblematico. Quando ho deciso di realizzare il film ho chiesto un aiuto organizzativo e logistico al sindacato delle costruzioni della Cgil, la Fillea, che mi ha dato una importante e significativa collaborazione e mi ha permesso di prendere contatto con i famigliari di lavoratori morti sui luoghi di lavoro e con lavoratori sia italiani che stranieri presenti sul nostro territorio in quattro regioni italiane, il Piemonte, il Lazio, la Campania e la Lombardia.
Noi ci siamo chiesti spesso come il sindacato – ma in generale direi la società – possa difendere la memoria delle migliaia di lavoratori che muoiono nelle fabbriche, nei cantieri, nelle campagne; se questo sia un suo compito e come possa non recidere il legame con chi resta, lasciandolo sprofondare nell’oblio e nella solitudine.
È una questione molto delicata, delicatissima, e in molti casi non è stato facile prendere contatto con le famiglie delle persone morte sui luoghi di lavoro, perché questo avrebbe prodotto comunque nuove sofferenze. Nella maggior parte dei casi il sindacato è stato un giusto tramite, e mi ha permesso di avvicinare queste famiglie, di avere la loro disponibilità a venire sul set dove facevo le riprese del film e ad essere intervistati. E mi fermo qui, nel senso che sinceramente io non sono entrato nel dettaglio rispetto alla qualità dei rapporti tra queste famiglie e il sindacato. Ho affrontato la dinamica dell’incidente e il modo in cui loro hanno vissuto questa situazione ovviamente drammatica, che gli ha stravolto la vita dal momento in cui è arrivata la maledetta telefonata che inizia il racconto del film. Da allora la loro vita si è trasformata, ed è diventata un incubo. La signora che ha avuto il figlio e il marito morto nel giro di quindici mesi invece l’ho conosciuta grazie a un giornalista di “Ballarò” che mi ha mandato una mail perché aveva letto che io stavo iniziando la preparazione di questo film, e visto che aveva incontrato questa signora mi indicava il suo nominativo e mi proponeva di prendere contatto con lei.
Quanti, tra coloro che ha intervistato, erano delegati o quadri sindacali?
Pochissimi, ad esempio un paio di ragazzi di origine nigeriana che lavorano in Lombardia, se non erro quelli che parlano del caporalato. Io non ho voluto in questo film nessun sindacalista, volevo solo lavoratori. E da parte del sindacato la mia richiesta è stata accolta con grande sensibilità; si sono dati da fare molto bene in quasi tutte le realtà dove sono stato.
Lei ha spesso collaborato con la Cgil, in particolare ricorderei il film Partitura per volti e voci. Viaggio tra i delegati Cgil, del 1991.
È stata un’esperienza straordinaria, e anche problematica per la discussione che ha creato all’interno del sindacato. Io non sono un regista di propaganda, il cinema di propaganda io non lo definisco cinema, è un’altra cosa. Un cinema d’intervento è un cinema che deve essere in grado di analizzare e di raccontare la realtà, e di porre all’attenzione anche delle questioni che sono problematiche e contradditorie. Così mi sono posto anche davanti al viaggio attraverso i delegati di base della Cgil. Ed è chiaro che chi si aspettava un film che dicesse “siamo belli, siamo forti e vinceremo” non ha trovato corrispondenza, ma ha trovato questioni che ancora oggi rappresentano un nodo problematico con il quale il sindacato deve confrontarsi. Io allora sono stato molto sostenuto dall’Ufficio formazione nazionale, e sono veramente grato a chi mi ha dato quella straordinaria amicizia e soprattutto fiducia, lasciandomi fare esattamente quello che io volevo, senza nessun tipo di condizionamento. Penso che gli uomini del sindacato che mi hanno dato questa fiducia abbiano poi pagato il prezzo per questa concessione di libertà. Comunque è un lavoro che mi piace molto ancora adesso, a diciassette anni di distanza, e da quello che mi dicono è usato ancora come strumento attivo di formazione dei delegati. Un film dura nel tempo quando non è un semplice reportage ma un vero film, capace di racchiudere un senso di universalità, di diventare patrimonio di tutti e materiale su cui costruire pensiero.
Che tipo di disponibilità al racconto ha trovato nelle persone che ha intervistato?
Ha incontrato delle resistenze, delle preoccupazioni?
No, assolutamente no. Ovviamente nessuno si doveva sentire obbligato: sia i lavoratori che i loro familiari sono stati informati del progetto ed è stata chiesta loro l’eventuale disponibilità a incontrarmi, a fare una chiacchierata con me. Nel novantacinque per cento dei casi, chi si è presentato ha dato poi la disponibilità a essere filmato. In pochissimi non se la sono sentita. Il racconto per loro è stato da una parte un momento liberatorio, e dall’altra un momento civile, perché tutti potessero essere portati a conoscenza della cruda realtà che loro avevano vissuto e che stavano vivendo. Una realtà di grande abbandono e di profonda solitudine.
Quindi ha riscontrato nei testimoni la volontà di dare un contributo attivo, di impegno civile…
Assolutamente sì. Credo che questo sia stato il motivo principale per cui le persone hanno accolto l’invito a partecipare all’esperienza del film. Lo dice espressamente la sorella di quel lavoratore, Fausto, che è stato portato fuori dal cantiere e dichiarato vittima di un incidente in moto: l’auspicio è che queste cose non capitino mai più a nessuno. Questo caratterizza la qualità e i termini della sua testimonianza.
Allora potremmo dire che il suo è un “cinema utile” – questo è il titolo della retrospettiva che il festival “Le voci dell’inchiesta” di Pordenone le ha appena dedicato – anche nel senso che è un cinema che sa rendere utili…
Deve! “Cinema utile” è un’espressione che ho usato per molti miei lavori: un cinema in grado di intervenire, di sollevare delle questioni che riguardano delle urgenze sociali, di stimolare la riflessione e la cultura della responsabilità, specialmente nel caso di Morire di lavoro. Un cinema che possa essere speso nell’educazione e nella formazione, e che sia in grado di relazionarsi al paese reale e alle sue contraddizioni. C’è chi dice che io sono una voce contro: io credo di essere una voce per, per un impegno civile, democratico, e di reale cambiamento del grado di civiltà. Questo è il cinema utile e necessario, e nel caso dei miei film si è trattato spesso, non solo in questo caso, di viaggi estremamente difficili e dolorosi, ma necessari.
Il suo film mostra bene come l’avvicinamento a storie di infortuni porti inevitabilmente con sé l’analisi delle condizioni normali, quotidiane, del lavoro. E fa emergere con grande forza e allo stesso tempo pudore la consapevolezza delle proprie capacità, l’orgoglio del saper fare, di questi uomini “vecchi già a trent’anni”.
A me interessava proprio questo, non mi interessava fare qualcosa di sensazionalistico, di strumentalizzare la sofferenza, cosa alla quale la televisione, e non solo, ci ha abituato in quest’epoca. Al contrario, dovevo lavorare nell’interesse del movimento dei lavoratori e offrire una conoscenza del mondo del lavoro che, purtroppo, da molto troppo tempo non si ha più. Sembra quasi un altro mondo, in realtà è un mondo che è molto vicino a noi, è un mondo di cui il paese ha bisogno, ed è un mondo che sempre più non viene rispettato. Il che produce misfatti che sono da guerra civile. Deve essere trovata una soluzione che vada nella direzione del rispetto della dignità di queste persone, perché è una situazione veramente drammatica e intollerabile.
Fa impressione vedere i dati storici dell’Inail: dal 1951 in poi si è scesi sotto la soglia dei tremila morti all’anno solo a partire dal 1975, e da allora comunque la strage ha mantenuto proporzioni elevatissime.
Sì, però nel tempo contemporaneo sono stati superati i limiti di civiltà che permettono l’illegalità e di conseguenza l’affermazione del valore del profitto sopra e contro quello del rispetto della vita. Certamente ci sono sempre stati incidenti, incidenti gravi, invalidanti e mortali, nel mondo del lavoro, ma questo non significa prenderne atto e abbassare la testa, rassegnarsi con indifferenza. Io credo invece che proprio alla luce della modernità si debba affrontare la questione con più senso di responsabilità, maturità e soprattutto rispetto per le persone che quotidianamente rischiano sul fronte del lavoro la loro vita. Ecco il motivo per cui ho fatto il film. Comprendo la complessità del problema, ma credo che si debbano trovare delle soluzioni per garantire a tutti i lavoratori la tranquillità di uscire al mattino di casa e poter tornare a casa la sera.
Dal punto di vista delle scelte stilistiche ed espressive, lei ha optato per la cifra del lutto nel fondo nero, il primo piano e lo sguardo in camera, che viene a interrogare direttamente la coscienza dello spettatore, senza mai lasciargli tregua per un’ora e mezza.
Morire di lavoro non è un documentario facile.
Assolutamente sì! Diciamo che è una scelta vincolante, e non è la prima volta che faccio un film con questo stile. L’ho fatto in altre occasioni, ad esempio con l’uso del primo piano, ma in questo caso in particolare la volontà era proprio quella di trovare un equilibrio che potesse agganciare lo sguardo e la tensione dello spettatore per un viaggio difficile ma necessario. I lavoratori per troppo tempo invisibili con questo film vogliono riaffacciarsi e farsi conoscere per quello che sono, per la loro umanità, per la loro solitudine, per i loro sogni. E anche per il loro amore per quello che fanno, malgrado quello in edilizia sia un lavoro non solo faticoso, ma usurante.
Il film gira l’Italia in lungo e in largo da mesi, assieme a Daniele Segre. Come è stato accolto dal pubblico?
Non è la prima volta che accompagno così un mio film, l’ho fatto quasi sempre in questi trenta e passa anni di attività. Il rapporto col pubblico è necessario, anche perché il mio cinema è fuori dai circuiti normali. Io vivo da sempre sotto embargo, e quindi c’è una necessità di visibilità che devo conquistarmi giorno per giorno. E poi ho bisogno di relazionarmi col territorio per attivare un confronto reale. Quando mi è stata data l’occasione di incontrare il pubblico ho sempre vissuto delle esperienze molto intense. Proprio per come è concepito e realizzato, il film non ha nulla di scandalistico, ma approfondisce e fa capire: per questo le discussioni che sono seguite alle proiezioni sono state straordinarie, emozionanti. Pur sapendo che il film non è un film facile, e che il linguaggio che io uso è in controtendenza rispetto a quello della televisione, che ha condizionato e continua a condizionare la capacità di ascolto. Il film pretende dallo spettatore una disponibilità all’ascolto complicata, specialmente per come si è stati educati alla visione negli ultimi decenni.
Ciononostante sta avendo un grande riscontro di partecipazione, con presentazioni in tutta Italia e in tutti i luoghi.
È stato sorprendente il passaparola che si è creato intorno al film, grazie al quale sono arrivate e continuano ad arrivare richieste da ogni parte, da ogni luogo e da ogni realtà. Realtà sindacali ma anche industriali, come l’Associazione nazionale dei costruttori edili. Sono stato a Mineo, in Sicilia, a un mese di distanza dalla strage in cui sono morti cinque lavoratori, annegati in un depuratore del comune, e la proiezione è stata straordinaria, emozionante. Sono stato invitato dalle scuole edili, ad esempio a Taranto, e dal ministero del Lavoro a Brindisi. E poi da licei e istituti professionali di molte città. La settimana scorsa ho accettato l’invito degli studenti del liceo classico “Cristoforo Colombo” di Genova in autogestione. Tutte le esperienze sono state belle, ma quelle che mi hanno più colpito sono state proprio quelle con gli studenti: incontri bellissimi, perché di scoperta, da parte loro, del mondo del lavoro. Lo stesso posso dire delle proiezioni in ambito cattolico, nei cinema parrocchiali. A breve andrò a Padova accogliendo l’invito della diocesi. In generale, nel mondo cattolico ho trovato una grande attenzione, una grande sensibilità. Il territorio ha bisogno di questo tipo di riflessione per maturare nuove e importanti consapevolezze rispetto al valore della vita e a quello che vale la vita nel tempo che viviamo: poco o niente.
Le riprese di Morire di lavoro sono iniziate prima della strage della Thyssen Krupp del 6 dicembre scorso. Come ha influito quell’evento sulla lavorazione del film?
Ha accelerato solo il montaggio. La preparazione del film era cominciata nell’autunno del 2006, le riprese sono durate da marzo a novembre del 2007. Quando a Torino è successa quella tragedia arrivavamo da altri episodi altrettanto gravi. E continuiamo a esserci immersi: se pensiamo che il 17 ottobre di quest’anno in Italia sono morti otto lavoratori non possiamo dire altro che siamo di fronte a una strage continua. L’evento drammatico di Torino mi ha fatto accelerare i tempi di montaggio, che avevo previsto più tranquilli, spingendomi a chiedere un permesso al Centro sperimentale di cinematografia, dove insegno. Volevo essere pronto nei primi giorni di gennaio 2008, e il mio obiettivo simbolico primario era proprio che fosse la Camera dei Deputati a ospitare il film, perché io lo considero il luogo principe di espressione della democrazia. Ho avuto l’onore di avere questa possibilità, e certamente l’immane tragedia della Thyssen Krupp gli ha dato il carattere di urgenza.
Quell’evento ha messo in moto una produzione cinematografica e persino teatrale – penso al nuovo spettacolo di Pippo Delbono, La menzogna – inedita di questi tempi sul tema del lavoro. La classe operaia va all’Inferno, di Simona Ercolani, è stato distribuito da “La Repubblica”, mentre Thyssen Krupp Blues di Pietro Balla e Monica Repetto e La fabbrica dei tedeschi di Mimmo Calopresti sono addirittura stati presentati alla mostra del cinema di Venezia, con grande soddisfazione di Giorgio Napolitano. Anche se va precisato che nel caso di Thyssen Krupp Blues il lavoro sulla storia di vita di un operaio di quella fabbrica era iniziato prima, venendo ovviamente trasformato dalla tragedia. Come giudica nel complesso questa produzione?
Il film Morire di lavoro è stato rifiutato al Festival di Venezia, e questo mi ha lasciato amareggiato e molto perplesso. Ritengo che non tutti i film che sono stati fatti sull’onda emozionale della tragedia della Thyssen Krupp abbiano dei requisiti etici corretti rispetto alla causa che si propongono, e per la quale ci si dovrebbe impegnare: l’educazione e la formazione di una sensibilità e di un senso di responsabilità sulla sicurezza e non solo. Sono estremamente perplesso davanti a operazioni strumentali che hanno, come dire, “messo in scena” la sofferenza, esattamente l’opposto di quello che io credo debba fare un cinema utile.
Anche nel suo film la sofferenza si racconta con grande intensità: come stabilire il limite oltre il quale fermarsi?
In Morire di lavoro la sofferenza è rappresentata con grande e profonda dignità, e da parte dei protagonisti con estremo coraggio. Le faccio un esempio: ci sono stati dei momenti molto drammatici, di persone che si sono messe a piangere, anche disperate. Io ho bloccato tutto, ho spento la telecamera, li ho tranquillizzati, e nel momento in cui loro hanno riattivato la propria capacità di controllo e di analisi rispetto a quello che avevano vissuto, abbiamo ripreso la registrazione. Cioè, io credo che non si debba mai superare quel confine molto intimo e personale che può ledere la dignità delle persone, raccogliendo e documentando la loro profonda sofferenza. Non si può e non si deve, bisogna rispettare le persone, essere dalla loro parte, non fare uno spettacolo consolatorio che però non serve a niente.
Si riferisce in particolare alla registrazione della chiamata al 118 in cui si sente la voce di uno degli operai che avrebbero perso la vita, e che era stata inserita nel finale de La fabbrica dei tedeschi?
Quella è una vera e propria volgarità. Era stato chiesto con grande senso di umiltà da parte dei familiari di non utilizzare quella registrazione, ovviamente, e invece quella registrazione è stata utilizzata ed è anche stata accampata una spiegazione: l’aveva scritto Ezio Mauro su “La Repubblica” ed era rinvenibile sulla rete. Un risposta di profonda superficialità da parte del regista, che è stato poi obbligato a toglierla su richiesta dei parenti delle vittime e non solo. Questo è imbarazzante e offende tutti, non solo i lavoratori e i protagonisti del film, ma tutti quelli che vogliono costruire un’Italia diversa, basata sul rispetto di valori fondanti il nostro paese, e non su piccole speculazioni e banali protagonismi. Io assolutamente non sono d’accordo con quella scelta, non c’entra niente col cinema.
Io ho visto il film nella versione originale, e mi sono interrogata sull’uso di quella registrazione. Da un certo punto di vista quella voce di dolore era comunque un elemento di documentazione oggettiva di ciò che era accaduto, di come era accaduto.
Parlo per me, ma io sono convinto che la verità si debba raggiungere attraverso elementi di rappresentazione e di linguaggio molto diversi. La “messa in scena”, invece, delude e imbarazza.
Il suo film usa dei riferimenti espliciti all’identità nazionale: penso alla scelta delle regioni in cui lavorare, all’uso dell’inno, alle inquadrature di “cartoline” italiane come il Duomo di Milano o il Golfo di Napoli. A livello implicito poi, la condizione operaia che si racconta è sorprendentemente unitaria nelle sue caratteristiche di fondo, alla faccia delle “questioni” meridionali e settentrionali.
L’illegalità è un problema che riguarda l’intero territorio nazionale, nonostante in alcune regioni sia particolarmente acuto, e questo è drammatico. Quanto all’uso dell’inno nazionale, segnala che io riconosco ai lavoratori un’identità che è espressione del nostro paese. Il film termina con una inquadratura sull’Altare della Patria e con i dati dei morti in edilizia e in tutti i settori del lavoro, perché credo debba essere riconosciuta ai morti sui luoghi di lavoro la stessa titolarità e lo stesso onore dei caduti per la patria. Non solo sono persone oneste, che portano a casa il salario per dare un futuro alle loro famiglie, ma con il lavoro contribuiscono allo sviluppo del paese, al benessere di tutti.
Il problema è che questi “caduti per la patria”, come vuole chiamarli lei, non solo non hanno altari o altre forme di memoria pubblica, ma spesso non hanno nemmeno un nome e una storia sui giornali, e le loro famiglie non hanno giustizia nei processi.
È esattamente per questo che ho fatto il film, che ho prodotto e che sto distribuendo in modo indipendente con la mia società “I cammelli”, malgrado il cordone sanitario che mi hanno costruito intorno. Per questo ho deciso di attivarmi in un’azione di comunicazione sul territorio nazionale, proprio per contribuire a questa riflessione. Però sono in profonda solitudine, in quest’azione. Ho avuto la collaborazione e il sostegno del sindacato delle costruzioni della Cgil, e gliene sono molto grato, però è un’impresa epica: bellissima, meravigliosa, però complicata, molto complicata.
Ha altri progetti?
Resistere! Intanto, tutto questo 2008 l’ho dedicato alla diffusione e alla promozione del film, continuando nel mio lavoro di docente al Centro sperimentale di cinematografia di Roma e all’Università di Pisa. Vorrei fare altre cose ma sono solo, non mi basta una telefonata per avere le porte aperte. Devo inventarmi giorno per giorno una prospettiva di ricerca nel mio interesse artistico, e questo non è facile, oltre a essere molto costoso.
Tra l’altro Morire di lavoro è un film che potrebbe stimolare esperienze analoghe, offrendo un modello anche stilistico per la raccolta e la diffusione di memoria a molti livelli: anche “amatoriali”, in luoghi e ambienti che sono stati toccati da questa piaga.
Già in Partitura per volti e voci avevo usato il primo piano in questo modo. È senz’altro una scelta che può essere adottata in questi casi. Ma la cosa più importante è sempre la qualità del rapporto che chi sta dietro alla macchina da presa riesce a creare con i protagonisti delle storie. La qualità comunicativa che esprimono i protagonisti di Morire di lavoro è l’obiettivo indispensabile per costruire il vincolo tra lo schermo e lo spettatore. Non basta mettere la macchina da presa in un certo modo, bisogna realmente costruire le condizioni di un rapporto leale, onesto, che consenta alle persone di essere realmente se stesse. Solo così si produce qualità comunicativa: attraverso la fiducia. Mi è stata data una fiducia straordinaria, della quale sono molto grato, e senza la quale questo film non esisterebbe.